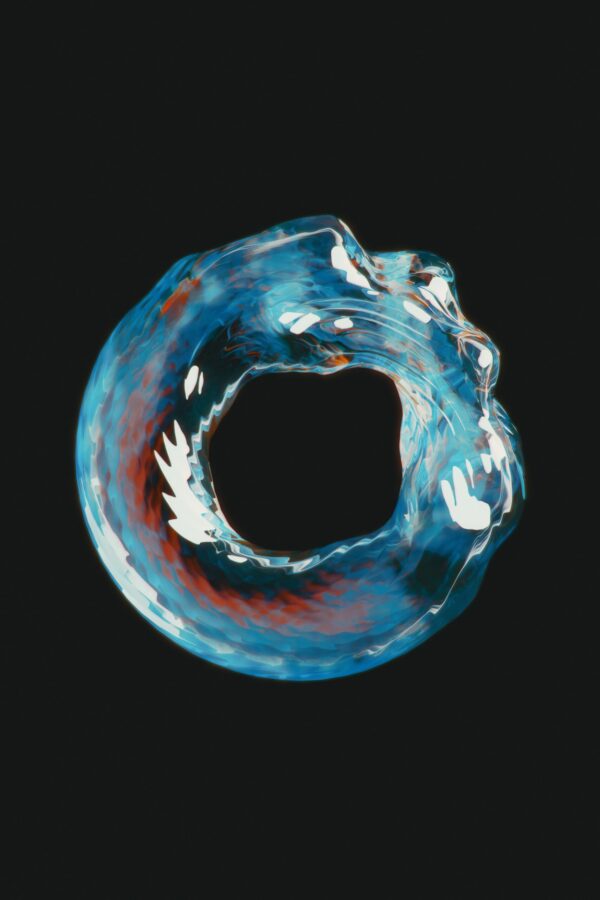Condivido alcuni estratti di un bellissimo volume di Mario Trevi (3 aprile 1924 – 31 marzo 2011) psicoanalista di orientamento junghiano, credo che questo volume sia molto utile a tutti coloro che si avvicinano al pensiero di Jung, sappiamo quanto le teoria junghiane degli archetipi e dell’inconscio collettivo possano affascinare, questo testo aiuta a leggerle in modo critico, per cogliere il genuino apporto innovatore che la psicologia analitica di Carl Gustav Jung a portato alla psicoanalisi.
Per uno junghismo critico. Interpretatio duplex di Mario Trevi (2000)
«A un esame più approfondito ci si rende conto, invero, che nell’opera di Jung si contrastano, da un punto di vista organizzativo e formale, due tendenze: quella di costruire una visione coerente e sistematica della vita psichica, confrontabile, in questo senso, ad altri numerosi approcci sistematici prodotti dalla speculazione psicologica del nostro secolo e quella della continua rottura della trama sistematica per dar spazio a un contenuto esperienziale che si ribella a ogni rigido inquadramento teoretico ma che si deve piuttosto riportare a originali opzioni euristiche difficilmente saldabili l’una all’altra». (Trevi, 2000, p. 5)
«La definizione “minima” di ermeneutica è quella dell’arte e della problematica dell’interpretazione in quanto processo di pensiero che mira all’intendimento o comprensione di un testo scritto o parlato. Dove per “testo” deve intendersi qualsiasi concrezione del pensiero e del sentire umani che si offre appunto all’intendimento di un interprete, e perciò, per estensione legittima, anche la parola e il comportamento dell’uomo comune che, veicolando significati espliciti o riposti, si offre alla comprensione di chi appunto lo riguarda con interesse interpretativo». (Trevi, 2000, p. 7)
«È il tempo di chiedersi ora come possano essere evidenziati i legami tra la psicologia analitica e l’ermeneutica e in che consista quella inconsapevole pertinenza ermeneutica dell’opera di Jung che sopra si è annunciata. In tutto Jung è vivo – e ne costituisce l’elemento differenziale rispetto agli altri grandi psicologi del nostro secolo – il problema della presenza ineliminabile del soggetto ricercante nell’oggetto della ricerca psicologica (Trevi 1975). Questa posizione che, come vedremo, è all’origine storica stessa della psicologia analitica, non porta Jung a un relativismo sterile e brevemente in sé concludibile, ma a un’apertura problematica estesa e sempre rinnovata, a un “domandare” inesauribile che chiede e rinvia ad altre domande, a uno “stile” inconfondibile di ricerca intesa come strenuo rimanere nell’ambito del problema interminabilmente aperto e, infine, al continuo trapasso dal logos della proposizione scientifica in sé conclusa al “dialogo”, in cui nessuno degli interlocutori pretende di assoggettare l’altro alla propria verità (Vattimo 1981, p. 73), perché nessuna verità circoscritta e completa è possibile attingere ma solo la verità come limite irraggiungibile che, definendo la “strada” della ricerca, la “mantiene” continuamente nell’ambito del ricercare». (Trevi, 2000, pp. 9-10)
«Per quanto tu possa camminare, e neppure percorrendo intera la via, tu potresti mai trovare i confini dell’anima: così profondo è il suo lògos». (Eraclito, frammento 45 Diels-Kranz).
«Questa posizione percorre tutta l’opera di Jung, fino alle ultime proposizioni e fino all’estremo risolversi di ogni «psicologia» come scienza oggettiva nella “psicologia” come struttura originaria e in ogni caso individuale del soggetto indagante. Non importa (e qui sta l’elemento contraddittorio di Jung che occorre chiarire e smascherare) che, accanto a questa posizione metodologica di strenuo ambito critico, appaiano, nel rapsodico disordine che è proprio di questo pensatore, proposizioni di cosiddetta scienza oggettiva (vale a dire naturalistica) della psiche, non importa che Jung, che pur tenta di smascherare il naturalismo della ricerca psicologica da cui proviene, cada continuamente nell’ambito di questo stesso naturalismo. L’importante è che l’atteggiamento iniziale sia, nonostante tutto, mantenuto e fecondi, esplicitamente o no, tutta la ricerca nei suoi punti nodali fondamentali: il problema del simbolo, la dinamica degli opposti, la funzione trascendente, l’autonomia (e la mutua dipendenza all’interno di una totalità organica) di ogni livello di esplicazione della vita psichica, l’individuazione e il dialogo mutualmente fecondatore come unico autentico strumento terapeutico.
Orbene, questa posizione di Jung, questa vis problematizzatrice che percorre tutta la sua opera, è di stretta natura ermeneutica se, appunto, per ermeneutica intendiamo quell’atteggiamento di pensiero che, ponendo il problema dell’interpretazione, deve considerare altresì il vivo e ineliminabile problema dell’interprete nei confronti del testo da interpretare e riconosce che non c’è testo «oggettivo», staccato e indifferente all’intrprete, ma testo diviene qualsiasi testimonianza del mondo della vita nel momento in cui un in-terprete l’assume nel suo orizzonte di interesse». (Trevi, 2000, p. 10)
«Nel 1913 Jung espone per la prima volta, con una comunicazione al Congresso Internazionale di Psicoanalisi, la propria teoria dei tipi psicologici […] impiegandola come espediente interpretativo della querelle allora attuale tra Freud e Adler. […] Vi si annunciava la legittimità sia dell’interpretazione della vita psichica proposta da Freud sia di quella proposta da Adler. Ma vi si annunciava altresì il principio per cui in ogni formulazione della vita psichica entra inevitabilmente e di diritto la vita psichica dell’interprete. Anzi, in tanto erano valide entrambe le dottrine allora concorrenti in quanto nascevano da una visuale bensì soggettiva e tuttavia non unica o inconfondibile dell’interprete, vale a dire di un “punto di vista” condivisibile da altri soggetti perché connaturato all’uomo attraverso la mediazione del “tipo psicologico” . Entrambe le dottrine erano interpretazioni legittime della vita psichica purché riconoscessero il limite connesso al punto di vista del rispettivo interprete. Da ciò conseguiva che non poteva darsi verità oggettiva relativa alla vita psichica che si potesse considerare autonoma, “staccata” e indipendente dall’angolo visuale dell’interprete, ma ogni dottrina interpretativa della vita psichica (e globalmente interpretativa perché implicante la nozione dell’inconscio come necessario complemento della vita cosciente) implicava di necessità la considerazione della visuale dell’interprete stesso. Vero è che Jung concludeva con l’auspicio che la psicologia de profondo raggiungesse quel “punto di vista superiore” entro quelle visuali parziali dovute all’atteggiamento tipologico, fossero ricomprese. Tale “punto di vista superiore” poteva bensì condurre la psicologia a una scienza “oggettiva” ma, risolvendosi, almeno in quel momento, nell’aspirazione a una teoria completa dei tipi psicologici, rispettava la posizione euristica e sostanzialmente ermeneutica allora raggiunta da Jung. Dal 19 I 3 al 1921 una parte del suo pensiero creativo si muoverà appunto lungo la direttiva della costruzione di una teoria completa dei “tipi” e pertanto lungo una direttiva autenticamente ermeneutica». (Trevi, 2000, p. 11)
«Si mediti a tal proposito su questa proposizione: “Noi non facciamo che ricondurre i simboli un po’ più indietro, traendo alla luce del sole una parte del loro regno, senza però cadere nell’errore di ritenere di avere con ciò creato qualche cosa di più che un nuovo simbolo per quello stesso enigma, che enigma è stato per tutti i tempi che ci hanno preceduto. La nostra scienza è anche essa linguaggio figurato” (Jung 1921, p. 257). In questo asserto junghiano è contenuto, a ben vedere, tutto un programma ermeneutico purché non ci si fermi alla superficie del discorso ma si tenti di penetrarlo al di là del suo primo apparire. È chiaro, innanzitutto, che Jung non ritiene la psicologia (la “nostra scienza”) qualcosa di apparentabile alle scienze della natura e alla loro pretesa nel loro ambito legittima – di enucleare una volta per tutte i significati ultimi delle apparenze delle cose, codificandoli in leggi e in costituenti universali». (Trevi, 2000, p. 16)
«La psicologia dunque è la continua costruzione di un universo di linguaggio simbolico, o, per meglio dire, metaforico che, mentre non pretende affatto di esaurire l’enigma attorno a cui si travaglia, lo “interpreta” via via aderendo ai limiti e all’intenzione dell’interprete, rispettando la storicità e la concreta esistenzialità di quest’ultimo. La psicologia è linguaggio metaforico che schiude di volta in volta un nuovo orizzonte di comprensione e immediatamente ne riconosce i limiti, permettendo e al contempo appellandosi ad altri possibili orizzonti di comprensione». (Trevi, 2000, p. 17)
«Il medico non è un osservatore neutro ma la sua possibilità di comprensione è messa in questione dalla possibilità di comprensione dell’altro, così come è vero il processo opposto e complementare. Medico e paziente sono entrambi chiamati a interrogare ognuno se stesso per la ricognizione di quei limiti della propria visuale oltre i quali si schiude alla comprensione la visuale dell’altro. Medico e paziente sono richiamati a interrogarsi reciprocamente e a mantenere aperta la domanda affinché non si sclerotizzi in una verità di comodo e perciò in una falsa verità». (Trevi, 2000, p. 20)
«L’uomo è il testo che interpreta il suo interprete; l’analizzando è il testo che occorre liberare, nell’atto interpretativo, perché possa, interpretando l’analista, riacquistare ogni sua originaria libertà interpretativa, che è la stessa possibilità che lo fonda categorialmente come uomo integro e libero». (Trevi, 2000, p. 21)
«Risulta per lo meno difficile comprendere l’irriducibilità dell’opposizione tra l’individuo e la sfera onnicomprensiva degli elementi collettivi, poiché appunto l’individuo non è che una “scelta” particolare di elementi di detta sfera». (Trevi, 2000, p. 28) NOTA: L’individuo non è che una particolare configurazione unica di elementi universali.
«[…] Il lettore di Jung ben conosce i due significati della parola “psicologia” che si alternano nel testo junghiano: “scienza della psiche” e “manifestazione della psiche” o, se vogliamo, “discorso sulla psiche” e “discorso della psiche”. Questo slittamento semantico non costituisce però un difetto del testo di Jung, ma, al contrario, la premessa di quel dissolversi di ogni “discorso sulla psiche” nel “discorso della psiche” che costituisce uno dei risultati più originali e fecondi della meditazione junghiana». (Trevi, 2000, p. 30)
«Ricordiamo che l’individuo è, per definizione, composto di contenuti elementari collettivi, aggregati secondo proporzioni diverse». (Trevi, 2000, p. 32)
«Non si tratta infatti, stando alla definizione junghiana, di “formare” alcunché di nuovo, ricavandolo dall’immensa matrice delle determinazioni collettive ma, tutt’al più, di liberare qualcosa di già “formato”, di separare dalle scorie degli elementi collettivi non pertinenti qualcosa che è già dato all’inizio in una sua chiusa ed esaurita fattualità. […] L’individualità, dunque, è “già data”, ma è inconscia: il processo di individuazione consiste (e si riduce) nel portare a coscienza questo “già dato”. Il passaggio implicito dalla potenza all’atto è tutto determinato dal passaggio dallo stato inconscio a quello cosciente». (Trevi, 2000, p. 34)
«Nella definizione di “individuo” si dice: “L’identità dell’individualità con l’oggetto rivela chiaramente il carattere inconscio di quest’ultima”. Nella definizione di “individuazione” si dice “L’individuazione coincide con l’evoluzione della coscienza dall’originario stato di identità” e si rimanda direttamente a questo concetto e alla sua definizione (Jung 1921 a, p. 464)». (Trevi, 2000, p. 35)
«L’individuo non è garantito né dalla sua origine né dal suo fine: esso si costituisce e decostituisce continuamente a contatto e nell’interscambio con gli altri individui in quel vivente magma che è la cultura. Il suo stretto inserimento nella cultura, che continuamente lo plasma, garantisce la sua storicità ma non ne determina la passività. Se l’individuo deve continuamente porsi problemi di opposizioni laceranti e di sintesi componenti (come, nell’esperienza clinica, Jung ha ben visto) è appunto perché la cultura che lo plasma si costituisce anche come minaccia alla sua creatività, come mortificazione e reificazione, come assoggettamento e spegnimento». (Trevi, 2000, p. 49)
«Il cammino – pur sempre non garantito dell’individuo (e fatto di ripensamenti, indugi, bivi paralizzanti e ritorni) – è quello che va dal suo essere prodotto della cultura al suo esserne produttore. Questa direzione orizzontale dell’individuazione non deve in alcun modo esautorare quella che abbiamo chiamato direzione verticale dell’individuazione stessa e che costituisce il massimo interesse di Jung». (Trevi, 2000, p. 49)
«Ecco perché, mentre occorre prendere attente distanze critiche nei confronti della datità dell’individuo che abbonda nelle definizioni junghiane, si può accettare l’apparente stranezza di un individuo tutto costituito di elementi collettivi, che in un primo tempo ci era sembrata di derivazione positivistica e di impostazione quantitativa. Tale apparente stranezza rende conto della stretta connessione tra individuo e cultura così come della complessa interazione tra i due. Non c’è elemento dell’individuo che non appartenga alla cultura ma non c’è movimento della cultura che non venga elaborato nel vivente organismo dell’individuo». (Trevi, 2000, p. 50)
«Da una parte l’individuo si costituisce come tale passando da uno stato di indifferenziazione a uno stato di differenziazione (junghianamente, da uno stato di identità inconscia a uno stato di disidentificazione conscia); dall’altro l’individuo si costituisce nel periglioso e controverso passaggio dallo stato di “fatto” della cultura allo stato di “fattore” della stessa». (Trevi, 2000, p. 51)
«La straordinaria ricchezza simbolica caratterizzante l’immaginazione inconscia che accompagna (e probabilmente in gran parte determina) il processo di individuazione è solo un aspetto della più vasta ricchezza immaginale dell’uomo e comunque testimonia se assunta in questa prospettiva di non far parte di una sovrastruttura aleatoria, fittizia e in fondo inutile, ma, al contrario, di una struttura fondamentale, capace di determinare proprio quelle condizioni che costituiscono l’individuo come produttore di cultura. La vita immaginale dell’uomo è parte della struttura e non della sovrastruttura». (Trevi, 2000, p. 52)
NOTA: la cultura che forma l’individuo secondo la società del tempo, anche consegna all’individuo le forme per la sua rivoluzione e evoluzione interiore, soltanto che mentre le forme che fanno dell’uomo un prodotto della cultura sono coscienti e note, quelle che fanno dell’uomo un produttore di cultura sono nascoste nella memoria della cultura stessa.
«[…] la cultura, essendo vivente organismo e perciò conservazione del passato e memoria, foggia bensì l’individuo secondo il suo canone conscio ma trasmette al contempo all’individuo stesso anche il deposito intero delle sue forme e perciò pure di quelle obliate e occultate al di sotto della dominanza storica del canone culturale momentaneamente accettato». (Trevi, 2000, p. 57)
«Dimodoché l’individuo riceve dalla cultura una doppia eredità: quella delle forme, dei valori e dei modelli consci, e quella delle forme, dei valori e dei modelli sommersi trasmessi dall’aspetto di “memoria” della cultura stessa». (Trevi, 2000, p. 57)
«La cultura come memoria plasma la memoria inconscia dell’individuo e pertanto gli trasmette un tesoro immenso di stimoli alle sue possibilità creative». (Trevi, 2000, p. 57)
«Le dinamiche – che possiamo intuire drammatiche e complesse – stabilentisi tra l’Io plasmato dalla cultura e le forme obliate della cultura stessa costituiscono un capitolo ancora in parte inesplorato della psicologia analitica, impedita, in questa esplorazione, dal canone culturale della concezione archetipica». (Trevi, 2000, p. 57)
«Ogni rivoluzione autentica è ripensamento di un passato obliato e creazione di un futuro inesplorato». (Trevi, 2000, p. 58)
«Né la direzione verticale né quella orizzontale dell’individuazione garantiscono dunque la positività della trasformazione della cultura. Ciò che invece l’individuazione permette è la liberazione sia da una concezione pessimistica della cultura vista unicamente come repressione della natura istintiva dell’uomo (che conduce all’immobilismo di un adattamento mortificato), sia da una concezione ugualmente pessimistica della cultura vista unicamente come ideologia (che si ribalta in un ottimismo utopistico-messianico tanto solenne quanto ingenuo). L’individuazione – se correttamente intesa – comporta sia l’assunzione individuale della vita pulsionale, riscattata dalla repressione esercitata dalla cultura, sia la liberazione dalla falsa coscienza determinata dalla curvatura ideologica della cultura. E ciò perché l’individuazione è innanzitutto assunzione critica che evita gli opposti pericoli di una sottomissione passiva e di un rifiuto pregiudiziale e irriflesso». (Trevi, 2000, p. 59)
«Se l’individuazione non garantisce (cosi come non è garantita, conservando sempre il suo significato di rischio) non per questo essa non svolge un fondamentale compito antropologico. Essa, che, dal punto di vista dell’individuo astrattamente inteso, può essere considerata meta e conclusione dei fini psicologici, dal punto di vista della cultura e della società, può essere considerata la premessa indispensabile del costituirsi dell’uomo come individuo responsabile della storia dell’uomo stesso. Dove responsabilità non annulla il rischio del fallimento e della sconfitta, ma colloca tale rischio in quell’orizzonte di possibilità dischiuso dalla coscienza liberata». (Trevi, 2000, p. 60)
«Se la psicologia del positivismo – a parte la ricchezza delle osservazioni e delle sperimentazioni – si era risolta nell’assidua ricerca delle determinanti ultime dell’agire individuale, l’introduzione sempre più massiccia della nozione di inconscio, con Janet e con Freud, aveva riproposto una scienza rigorosamente deterministica della psiche, la cui novità metodologica consisteva unicamente nello spostamento a livelli inconsapevoli della motivazione ultima di ogni funzione psichica, dalla percezione alla memoria, dall’emozione al sentimento, dal pensiero alla decisione operativa». (Trevi, 2000, p. 62)
«Jung, storicamente sensibile – al di là della grande stagione del positivismo – alla tradizione kantiana delle “possibilità” costitutiva dell’uomo e a quella goethiana dell’ineffabilità e unicità dell’individuo, fa di quest’ultimo il centro della sua considerazione psicologica, situandolo nella doppia dimensione dei nessi causali che – in ogni evento dell’esistere – precedono l’individuo stesso e delle intenzioni finalistiche verso cui, nell’evento, l’individuo si protende, sia pure con un atto di scelta non incondizionata. L’ospitare nella psicologia la nozione di fine (liberamente anche se condizionatamente scelto) costituiva un rischio pericoloso rispetto alla normativa metodologica della psicologia della sua epoca, perché quella nozione svelleva di colpo la psicologia stessa dal tronco delle scienza della natura su cui il positivismo l’aveva faticosamente costituita». (Trevi, 2000, p. 62)
«La psicologia: non le pulsioni o i desideri o i bisogni erano il centro di quell’interesse, ma l’ineffabile e irriducibile concrezione individuale che quelle pulsioni, quei desideri e quei bisogni assume su di sé e declina di volta in volta in modo differente e di fatto imprevedibile, secondo una struttura in parte originaria e in parte diversificantesi nell’infinita interrelazione dei nessi che legano l’individuo a individuo e individuo a cultura». (Trevi, 2000, p. 63)
«Data l’originaria coincidenza del soggetto e dell’oggetto in ogni considerazione psicologica (talché l’uno non può mai costituirsi a osservatore indifferente dell’altro, ma ognora e irrimediabilmente è in esso coinvolto), la visione particolare del, soggetto indagatore, che sempre ingloba un fine costitutivo (vale a dire la convergenza strutturale dell’uomo in ogni pregiudiziale visione del mondo), opera di necessità una scelta nel cosiddetto materiale dell’osservazione e lo edifica in modelli probabili, relativistici, parziali e, appunto, finalisticamente orientati. Anche qualora la nozione di fine potesse essere rigorosamente espunta dall’oggetto della considerazione psicologica, essa vi sarebbe inevitabilmente reintrodotta da quel perenne sconfinamento reciproco tra soggetto e oggetto che è costitutivo dell’episteme psicologica. L’individuo che Jung, al nascere della sua concezione originale della psicologia, assume come unico centro concreto della considerazione psicologica non ha peraltro nulla in comune con l’individuo atomisticamente inteso della scienza positivistica». (Trevi, 2000, p. 63)
«[…] l’ammissione dell’Io come organo di discriminazione e di scelta e pertanto, contro l’imperante demonizzazione dell’Io in tanto junghismo contemporaneo, inconsapevolmente seguace di uno strutturalismo acritico e di maniera, implica altresì una vigorosa rivendicazione dell’operatività ineliminabile del principio egoico. L’aggettivo «critica» con cui si connota il sostantivo «assunzione» vorrebbe garantire
l’individuazione stessa contro ogni necessitarismo storico-culturale e schiudere al contempo una prospettiva «dialogica», perennemente aperta, tra individuo e cultura o, in termini junghiani, tra individuo e collettivo». (Trevi, 2000, p. 68)
«[..] Proporre due facili schemi adatti alla comprensione (comunque non esaustiva) di quel fenomeno peraltro unico e inscindibile che è l’individuazione. I due schemi verranno chiamati, per convenzione provvisoria, “schema interpersonale” e “schema intrapsichico”. L’elemento operativo del primo è la personalità assunta nel suo insieme e nella serrata interazione con l’ambiente sociale in cui, ininterrottamente, si struttura, si destruttura e si trasforma. L’elemento operativo del secondo schema è invece l’Io nella sua continua interazione con le altre i-stanze endopsichiche che la metapsicologia junghiana – peraltro indefinita e aperta – assume in un modello probabile.
Il primo schema interpretativo sembra dominare nelle “Definizioni” dei Tipi psicologici (Jung 1921 a), il secondo ne L’Io e l’inconscio (Jung 1928 b). Il primo schema è atto a comprendere l’individuazione come processo di interazione tra individuo e individuo, tra individuo e gruppo (dal minimo gruppo della famiglia fino a quell’universale “gruppo” che è la società globalmente intesa) e tra individuo e cultura. In tale schema “interpersonale” è conveniente distinguere due sottoprocessi parziali e reciprocaniente integrantisi: il sottoprocesso della differenziazione e quello dell’assunzione critica (e dialogica) delle forme della cultura. Il sottoprocesso della differenziazione è atto a comprendere il progressivo (ma sempre reversibile) differenziarsi dell’individuo dalle primitive identificazioni con i modelli imposti dalla famiglia e dalle altre istanze della cultura. Il sottoprocesso dell’assunzione critica è atto a comprendere la progressiva (e anch’essa reversibile) assunzione delle forme e dei modelli culturali da parte della personalità, in modo tale, tuttavia, che tali forme e tali modelli siano anche criticati e, all’occorrenza, sostituiti da altre forme e da altri modelli che la personalità via via creatrice può inventivamente produrre.
Lo schema che s’è convenuto chiamare “intrapsichico” è atto a comprendere l’individuazione come processo di trasformazione interna della personalità. Anche in tale schema è conveniente distinguere due sottoprocessi parziali e reciprocamente integrantisi: il sottoprocesso della differenziazione dell’Io e il sottoprocesso dello stabilimento dei legami dialogici tra l’Io e le altre istanze endopsichiche. Il primo sottoprocesso si presta a intendere il progressivo (e reversibile) differenziarsi dell’Io dalla possibile identità con le altre istanze endopsichiche. Il secondo sottoprocesso si presta a intendere il progressivo (e anch’esso reversibile) stabilirsi di nessi dialogici tra l’Io e le altre istanze endopsichiche, talché ognuna di queste si configuri in un rapporto creatore – sempre mutevole e sempre suscettibile di crisi innovatrice – con l’istanza dell’Io». (Trevi, 2000, pp. 69-70)
«I due schemi illustrativi dell’individuazione sopra proposti, e i sottoprocessi parziali in essi implicati, devono essere concepiti come strettamente imperniati – si è già detto – sulla categoria della possibilità e radicalmente avulsi dalla categoria della necessità. Ciò vuol dire che ogni strutturazione interna o esterna è sempre connessa al rischio di destrutturazione e non è in alcun modo garantita da qualsivoglia “legge” di sviluppo naturalistico.
Se sembra opportuno insistere ancora una volta su questa condizione fondamentale di pensabilità dell’individuazione è perché, nel discorso di Jung, ricco e multistratificato ma anche asistematico e contraddittorio, si rende più volte sensibile una declinazione naturalistica che ha il suo risultato più negativo in una concezione necessitaristica dell’individuazione». (Trevi, 2000, p. 72)
«L’entelechia aristotelica è un modello valido per illustrare processi (naturali ma estremamente pericoloso se applicato al livello dell’uomo perché esclude ogni riferimento alla possibilità in quanto antitesi della necessità. L’uso junghiano dell’entelechia aristotelica denuncia chiaramente il versante naturalistico che occorre rifiutare in Jung […] Se, come spesso avviene, a “processo di individuazione” diamo il significato di successione inalterabile di stadi di sviluppo e, pertanto, non di processo aperto e indeterminato, ma di processione in cui tutto è stabilito e fissato ab initio, il determinismo è inevitabile, e il significato dell’originale apporto antideterministico di Jung è irrimediabilmente perduto». (Trevi, 2000, p. 73)
«Se l’antropologia sottesa all’universo psicologico di Freud è quella del fondamento pulsionale dell’agire umano e del suo correlato psichico che è il desiderio, l’antropologia sottesa all’universo psicologico di Jung è l’individuazione, con il suo correlato psichico del progetto». (Trevi, 2000, p. 74)
«Che il progetto, a differenza del desiderio, sia correlato al rischio, non solo dello scacco, ma anche dell’inautenticità, rappresenta indubbiamente un problema che la, psicologia positivistica ignora, ed è connesso al livello di complessità in cui l’antropologia del progetto si propone. […] Al pari del desiderio, che può esprimersi o rappresentarsi sia al livello conscio sia al livello inconscio, così il progetto si articola tra inconscio e coscienza a seconda che questa possa ospitarlo o meno nell’organizzazione delle sue forme logiche o immaginali. Poiché il progetto è sempre sintesi o “composizione” di opposti che il pensiero dirimente della coscienza mantiene separati, esso deve servirsi, almeno in molte circostanze, di altre forme di organizzazione – verbale e visiva – onde potersi in qualche modo formulare. Il progetto deve servirsi – come si vedrà meglio in seguito – di una logica “compositiva” che ha il suo strumento elettivo e il suo nucleo organizzatore nel simbolo». (Trevi, 2000, p. 75)
«Il simbolo è anzitutto il significante (linguistico o visivo) che reca il suo significato “nascosto” dentro di sé, al pari di una gestante che reca il figlio celato nel suo ventre. Il testo di Jung è assai esplicito in questo senso e sfrutta a fondo la metafora della pregnanza». (Trevi, 2000, p. 76)
«L’uso che in questo contesto si fa del termine “pregnanza” non ha nulla a che fare con l’abusata sostituzione sinonimica di “ricchezza” (metafora “morta”), ma vuole semmai sfruttare a fondo la dimensione metaforica ancora viva del termine stesso. Il simbolo è anzitutto il significante (linguistico o visivo) che reca il suo significato “nascosto” dentro di sé, al pari di una gestante che reca il figlio celato nel suo ventre. Il testo di Jung è assai esplicito in questo senso e sfrutta a fondo la metafora della pregnanza. Nel simbolo dunque il rapporto tra significante e significato non è del tipo che, nel contesto del discorso sul linguaggio, Saussure indicò quale struttura del segno linguistico. Purché sia esplicito il codice, ogni significante rimanda a un significato, e in questo rimando (che può perfettamente essere espresso dalla “barra” saussuriana) il significante esaurisce la sua funzione. Nel simbolo invece il significato rimane “nascosto” all’interno del significante, in modo tale che, almeno apparentemente, questo non “rimanda” ad alcunché: il significato appare assente». (Trevi, 2000, p. 76)
«I romantici (soprattutto F. Schlegel, Novalis e Schelling) avevano perfettamente individuato questa dimensione del simbolo. Per essi il simbolo è carico di “senso”, ma non ha significato. Il merito di Jung è quello di aver riscattato dall’oblio, in cui l’epoca positivistica l’aveva relegata, una concezione del simbolo che i romantici avevano perfettamente individuato e che corrisponde a un’insopprimibile funzione della psiche». (Trevi, 2000, p. 77)
«Se per “progetto” intendiamo correttamente l’anticipazione delle possibilità proprie dell’individuo nel suo farsi tale e riconosciamo al progetto la sua possibile natura inconscia, allora il simbolo si configura come la più adeguata espressione di quel “non-ancora” che il progetto comporta: rappresentazione allusiva – tanto vivace quanto necessariamente oscura – di una condizione non ancora ospitabile nella coscienza». (Trevi, 2000, p. 77)
«Se il progetto è anticipazione delle possibilità, tale anticipazione può essere “formu-
lata” anche nel linguaggio dell’inconscio. Ciò significa che, in tal caso, è formulata appunto in simboli, vale a dire in espressioni verbali o visive che, benché cariche di “senso”, non hanno alcuna precisa dimensione semantica.
L’ammettere la produzione di simboli, nello specifico senso junghiano, da parte dell’inconscio, permette di concepire l’inconscio stesso non solo come il custode del passato (nella forma del rimosso), ma anche come custode del futuro, per quanto questo sia esprimibile appunto in progetti. Con Jung la concezione dell’inconscio si estende incomparabilmente, non perché egli faccia dell’inconscio, oltre il depositario del rimosso, anche il depositario di “immagini” o di “forme a priori” universali, ma perché egli riesce a concepire l’inconscio come produttore di progetti che la coscienza non potrebbe formulare. Non è l’inconscio “collettivo” a costituire l’apporto innovatore di Jung ma l’inconscio “creativo”». (Trevi, 2000, p. 78)
«Nel simbolo, per i romantici, vengono “compresi” (nel senso etimologico di “presi assieme”) gli opposti che di necessità il pensiero razionale e strumentale separa e, nella mutua esclusione, distanzia (Todorov 1977, pp. 239 e segg.)». (Trevi, 2000, p. 78)
«Il pensiero simbolico “compone” ciò che il pensiero razionale necessariamente disgiunge e “contrappone”. La mente dell’uomo si articola tra due modalità fondamentali di pensiero: quella dirimente dell’intelletto e quella componente dell’attività simbolica». (Trevi, 2000, p. 79)
«Se il simbolo, nell’accezione specifica in cui Jung assume questo termine sconfinatamente polisemico, non rimanda ad alcun significato, ma “trattiene”, per così dire, il significato dentro di sé, come la metafora della “pregnanza” precisamente esprime, non per questo esso si sottrae a un’attività interpretativa che tenti, sia pure inesauribilmente, di produrre significati adeguati». (Trevi, 2000, p. 79)
«Possiamo dire che il simbolo, sul piano della pratica ermeneutica, stimola illimitatamente la produzione di comprensioni, e che pertanto questa produzione inesauribile fa parte della dinamica del simbolo e ne è dunque un aspetto costitutivo […] Ogni comprensione esaustiva possibile è applicabile solo al simbolo “morto”, vale a dire al simbolo che ha ormai esaurito la propria “pregnanza” e, avendo prodotto un significato puntuale e univoco, si è trasformato in “segno”». (Trevi, 2000, p. 80)
«La novità introdotta da Jung sta anzi proprio nell’aver riscattato una modalità di produzione psichica dall’oblio operato dalla psicologia positivistica». (Trevi, 2000, p. 81)
«La prima formulazione junghiana del simbolo (Jung 1921 a, pp. 483 e segg.) viene infat-ti proposta in rapporto oppositivo alla concezione freudiana. Per Freud il simbolo ha lo statuto – netto e ben circoscritto – della significazione indiretta. Ciò vuol dire che per lui, nel simbolo, un significante rimanda sempre a un significato univoco e perfettamente individuabile, purché si conosca il codice – peraltro assai semplice – che è sotteso a quel rimando Il simbolo esprime in maniera indiretta ciò che non può essere, come tale, accolto dalla coscienza, per limpide e inequivocabili ragioni di difesa. In quanto tale, il simbolo “traveste” un contenuto inaccettabile dalla coscienza e, con questo travestimento, lo rende in qualche modo accettabile. Il simbolo si riferisce pertanto – sempre ed esclusivamente – a un contenuto pulsionale rifiutato dalla coscienza (Jones 1916); a un contenuto rimosso, che, nel suo tragitto di “ritorno”, non può non “travestirsi” ed esprimersi indirettamente.». (Trevi, 2000, p. 85)
«Jung intuisce che, a rigore, non si dovrebbe parlare di simbolo se non legando strettamente il simbolo stesso all’attività che lo suscita e che esso stesso, nella sua vitalità, suscita. Perfettamente intuisce soprattutto questa seconda attività: il simbolo “agisce” (Jung 1921 a, p. 486).». (Trevi, 2000, p. 86)
«[…] Noi dobbiamo dire che un simbolo autentico può essere concepito solo in stretto rapporto all’attività “componente” che lo produce e all’attività altrettanto “componente” che esso produce. Un simbolo autentico è un particolare “fatto”, un pragma che può essere afferrato solo in stretta indisgiungibile connessione con l’attività produttrice e prodotta a cui necessariamente rimanda, solo con l’érgon da cui scaturisce e che da esso prende origine». (Trevi, 2000, p. 87)
«Con queste immagini necessariamente elusive s’è voluto ribadire l’impossibilità di separare il simbolo dall’attività che lo produce e che esso produce: il fatto dall’atto, il simbolo dalla funzione simbolica. Da questo punto di vista forse cominciamo a comprendere perché il simbolo è oggetto di un’infinita attività interpretativa e sopporta infinite comprensioni. Il significato che il simbolo vivo trattiene presso di sé è l’infinita attività componente che lo precede e che lo segue». (Trevi, 2000, p. 88)
«Quale che sia il testo che ospita il simbolo (poesia, visione mistica, sogno o umile reverie quotidiana), tale testo si lacera nel punto in cui il simbolo si rende manifesto, sia pure per un lampeggiante momento. In questo momento avviene qualcosa di straordinario nella psiche che percorre quel testo. Noi possiamo chiamare in molte e diverse maniere questa eccezionalità o singolarità: salto qualitativo, trasformazione, crisi o persino catastrofe. In ogni caso si tratta di una trasmutazione: una vita psichica si apre all’attività compositrice che dal simbolo è prodotta, scopre nuovi percorsi e nuovi accessi, per l’innanzi impediti dalla consuetudine ottundente del quotidiano e dal regime rigido e dirimente del raziocinio». (Trevi, 2000, p. 88)
«Ma occorre fare attenzione: chi sancisce la natura del simbolo autentico è la coscienza. “Che una cosa sia un simbolo o no dipende anzitutto dall’atteggiamento della coscienza che osserva” (Jung 1921 a, P· 485 ). Al di fuori di questo atto costitutivo non c’è simbolo ma più o meno logora figura del linguaggio, talvolta emblema, talaltra soltanto inutile curiosità antiquaria. […] È la coscienza che fa del simbolo “la cifra della propria trasmutazione” (Corbin 1964, p. 178) ». (Trevi, 2000, p. 89)
«Nessuno psicologo, da Platone in poi, si è mai sottratto alla tentazione di descrivere oggettivamente la psiche, sia pure per mezzo di abbaglianti metafore. Jung non si sottrae a questa tentazione. Ma Jung ha introdotto nella psicologia il sospetto della sua non validità scientifica, della sua relatività, del suo radicamento nella soggettività. Qui sta la ragione per cui in Jung il discorso psicologico si duplica, si lacera ed entra drammaticamente in contrasto con se stesso». (Trevi, 2000, p. 92)
«Ma, nell’atto stesso di denunciare la soggettività ineliminabile di ogni psicologia del profondo, Jung non seppe sottrarsi alla tentazione di elaborare una psicologia esente dal più radicale relativismo dell’originaria disposizione psicologica del ricercatore. Nella presunzione dell’esistenza di un inconscio unico e originariamente universale, egli volle disegnare le linee di una psicologia “eterna”, sottratta alla storia, all’individualità psichica e al radicamento esistenziale del ricercatore (Jung 1932, p. 243). Così fin dall’inizio della ricerca tipicamente junghiana, fin da quegli anni che videro la pubblicazione di Trasformazioni e simboli della libido (1912) e, quasi contemporaneamente, del saggio Sulla questione dei tipi psicologici (1913), noi assistiamo allo sviluppo parallelo di due “moduli” costruttivi della speculazione junghiana: un modulo che, presumendo di afferrare le determinanti ultime del sentire, dell’immaginare, del pensare e dell’agire umani, si sforza di delineare una psicologia assoluta, intemporale e astorica; e un modulo che, consapevole dell’ineliminabile relativismo di ogni punto di osservazione psicologico, conduce a una posizione assai prossima a quella di Weber, vale a dire a quel consapevole relativismo che si sforza di ricuperare “l’oggettività” scientifica non “prima” ma “dopo” l’ineliminabile filtro della soggettività, e accetta, in maniera critica e matura, la parzialità della “scelta” euristica che la soggettività stessa impone». (Trevi, 2000, pp. 94-95)
«I due moduli si escludono reciprocamente e ognuno di essi può vigere e operare solo dove l’altro è assente e inattivo. Il loro intrecciarsi nell’opera di Jung non ha carattere antinomico perché non si può impiegare la negazione di un modulo per l’affermazione dell’altro, né complementare perché uno dei due, quello della “psicologia” ha carattere esaustivo e totalizzante e l’altro, quello della “considerazione psicologica”, giudica il primo come circoscritta parte in un discorso aperto e dal decorso imprevedibile. […] Quanto ora si è detto non esclude tuttavia che tra i due moduli si possa rintracciare, all’interno della stessa ricerca junghiana, una sorta di “circolarità”, talché il modulo costruttivo della “psicologia”, giungendo al limite di se stesso e perciò ponendosi in crisi, dia luogo al nascere del modulo costruttivo della “considerazione psicologica” e, viceversa, il modulo costruttivo della “considerazione psicologica”, ponendo in crisi, per la sua stessa natura, la propria fecondità, dia luogo, sia pure inavvertitamente, al modulo costruttivo della “psicologia”. La proiezione (in senso analogico-geometrico) di questa circolarità dà a sua volta luogo a un chiasma, una reciproca inversione di direzioni. La morfologia di questo chiasma, all’interno della ricerca junghiana, è ancora tutta da esplorare». (Trevi, 2000, pp. 96-97)
«Il dualismo dei due moduli costruttivi della “psicologia” e della “considerazione psicologica” sembra riflettersi anche in un altro dualismo della ricerca di Jung, quello di archetipo e di simbolo. Se gli archetipi sono quegli invarianti metastorici e universali dell’immaginazione – ma inevitabilmente anche del pensiero e dell’agire umani – di natura formale e non contenutistica in cui, dopo innumerevoli tentennamenti, Jung stesso sembra configurarli, allora essi rappresentano quel cosmo immutabile che, insediato nel più profondo dell’inconscio, dovrebbe rendere ragione dell’uniformità occultata nell’infinita varianza della cultura. […] Il simbolo invece, con i suoi caratteri di pregnanza semantica, sinteticità, intransitività e progettualità, è tutt’altro che un’ipostasi, ma un’attività o funzione che, elaborando contenuti sempre diversi, sempre si diversifica nel diversificarsi della cultura e della storia. È significativo, in questo senso, che la prima, complessa, ardua e purtroppo oscura definizione di “simbolo”, fornita da Jung (e alla quale egli sempre fedelmente si attenne) sia del tutto esente da ogni riferimento alla nozione di archetipo (Jung 192l a: definizione di “simbolo”)». (Trevi, 2000, p. 103)
Trevi M., (2000), Per uno Junghismo critico – Interpretatio duplex, Roma: Giovani Fioriti Editore

Psicologo clinico, Guida in pratiche Meditative, Facilitatore in Mindfulness (ric. IPHM), Master DCA (Disturbi del Comportamento Alimentare), Master in Sessuologia Clinica, Master in Linguaggi della Psiche, Conoscitore in psicosomatica