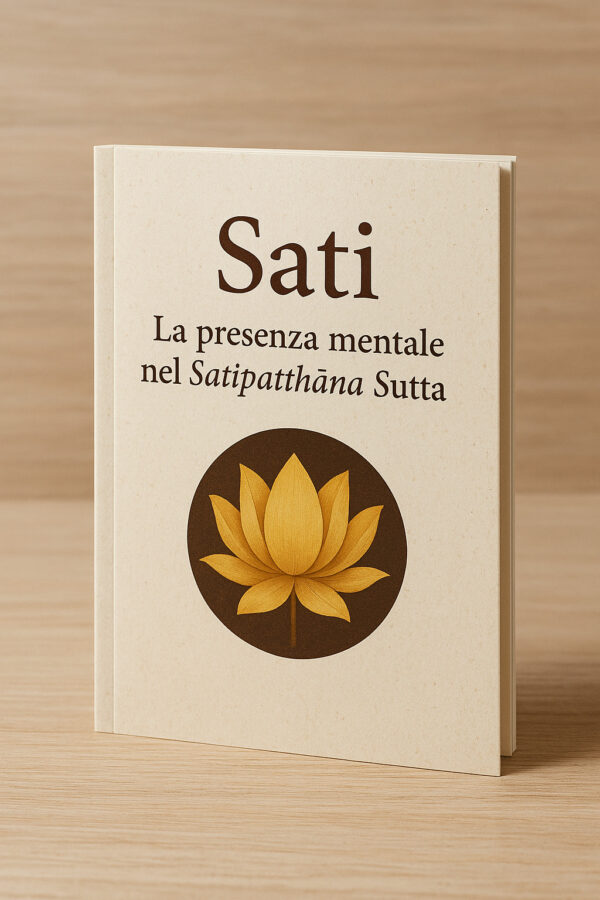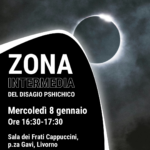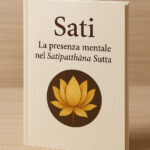Di seguito la trascrizione del contributo video.
In questo articolo
Percezione e sensazione: qual è la differenza?
Cos’è la percezione?
La percezione si differenzia dalla mera sensazione. Allora, la percezione cosa significa?
È il processo di risalire dalla sensazione alle cause nel mondo esterno che l’hanno generata. È un’operazione complessa perché non abbiamo accesso diretto alle cause nel mondo; siamo sempre separati da esso dal velo sensoriale. Attraverso il nostro apparato sensoriale non abbiamo accesso diretto, quindi dobbiamo compiere un processo inferenziale, ovvero fare un’inferenza probabilistica su quali siano le cause che possono aver generato la sensazione. Non abbiamo mai la certezza assoluta.
L’inferenza secondo Helmholtz
Questa idea della percezione come inferenza risale a Helmholtz, che cercava di capire come gli a priori kantiani, ovvero le categorie che utilizziamo per interpretare il mondo, potessero rimanere ancorati alla realtà del mondo e non essere completamente arbitrari. Helmholtz propose per la prima volta quest’idea della percezione come processo inferenziale.
Esempio: un rumore nella notte
Facciamo un esempio: supponete di essere nella vostra sala di notte e, all’improvviso, sentite un rumore.
Nella vostra mente si affacciano immediatamente alcune ipotesi sulla causa di quel rumore, come l’idea che ci siano dei ladri oppure che sia caduto un ramo sul tetto. Come fate a giudicare quale ipotesi è più probabile?
Vi sono due tipi di informazioni importanti:
- Quanto bene combaciano le prove (ovvero l’evidenza sensoriale) con l’ipotesi scelta
- Quanto è probabile l’ipotesi in sé stessa
Ad esempio, se scegliete l’ipotesi che un ramo sia caduto sul tetto, il suono che avete sentito corrisponde bene a quello dell’infrangersi del vetro del lucernario.
Se il giorno prima avete sentito dire che ci sono stati dei ladri nel vicinato, l’ipotesi che ci siano ladri nella vostra casa avrà già una maggiore probabilità a priori prima di aver sentito il rumore.
Verosimiglianza ed evidenza a priori
Questi due tipi di informazioni sono chiamati in gergo statistico:
- Verosimiglianza dell’evidenza (cioè quanto l’evidenza è verosimile data l’ipotesi)
- Probabilità a priori dell’ipotesi
Questo modo di procedere, questo processo inferenziale, era stato descritto già nel 1700 da un prete presbiteriano, filosofo e matematico di nome Thomas Bayes e va sotto il nome di “teorema o regola di Bayes”.
Introduzione al concetto di probabilità a posteriori
Il concetto che abbiamo visto nello schema precedente riguarda la probabilità a posteriori di un’ipotesi sulle cause di una sensazione. “A posteriori” significa “dopo aver ricevuto il dato sensoriale”.
Questa probabilità è proporzionale al prodotto della probabilità a priori dell’ipotesi e della verosimiglianza dell’evidenza.
In altre parole, se una di queste componenti è forte, aumenta la probabilità a posteriori.
Sembra che il processo della percezione funzioni proprio in questo modo, in maniera iterativa: dopo aver ricevuto l’evidenza sensoriale, la probabilità a posteriori diventa la nuova probabilità a priori, che viene confrontata con nuove evidenze sensoriali.
Il confronto con un processo giudiziario
Questo processo è simile a quello che avviene in un procedimento giuridico.
I testimoni forniscono le loro testimonianze e, ogni volta, l’ipotesi sulla colpevolezza di un imputato viene aggiornata sulla base delle nuove evidenze, diventando la nuova probabilità di partenza.
Il contenuto della percezione diventa così l’ipotesi che in quel momento ha la maggiore probabilità a posteriori.
Il problema della corrispondenza
Tuttavia, c’è un problema: il cervello, per come è costruito e per una serie di problemi intrinseci alla corrispondenza tra stati del mondo e sensazioni generate, non può avere una corrispondenza biunivoca (una cosa corrisponde a una sola cosa).
Matematicamente, il problema è mal posto e non è pensabile che l’architettura neurale del cervello possa risolverlo in questo modo.
Modello gerarchico del cervello
Il cervello trova una soluzione approssimata al problema del riconoscimento delle cause tramite la costruzione di un modello interno generativo a struttura gerarchica.
Questo modello:
- Si sviluppa con l’esperienza
- Si deposita attraverso le connessioni sinaptiche
- Fornisce previsioni sui segnali sensoriali
La struttura gerarchica è importante: i livelli più elevati forniscono previsioni per gli stati dei livelli inferiori, mentre i recettori sensoriali calcolano la discrepanza tra previsione e dato reale.
Il processo di percezione e azione
Quindi, sulla base della nostra ipotesi iniziale e della nostra previsione, chiediamo qualcosa al mondo, e il mondo ci risponde con dati che di solito non combaciano perfettamente con ciò che avevamo previsto.
La discrepanza è l’unico segnale che viaggia all’indietro verso i livelli superiori del cervello. Quindi, l’unica informazione importante è l’errore. Filosoficamente, questo è molto interessante.
Mente predittiva: passività e azione
Finora abbiamo trattato la mente predittiva in modo passivo, ma gli organismi viventi si distinguono per la capacità di agire. L’azione aumenta l’efficacia del processo inferenziale.
Agire per verificare
In presenza di ipotesi in competizione, possiamo agire per verificare quale sia più probabile.
Ad esempio: pensate che ci siano ladri? Andate a controllare la porta sul retro.
Se vedete segni di scasso, l’ipotesi è confermata. In caso contrario, l’errore di previsione riduce la probabilità di quell’ipotesi.
Due strategie per minimizzare l’errore
- Percezione → cambiare l’ipotesi
- Azione → cercare un dato sensoriale diverso
La modalità attiva è simile a una profezia autoavverante: cerchiamo ciò che abbiamo predetto.
Questo può sembrare rischioso, ma è molto utile in contesti ambigui o rumorosi.
Esempio nella nebbia
Se vi trovate in una fitta nebbia come in una scena di Amarcord, vi affidereste più alla vostra mappa mentale (acquisita camminando) che ai segnali visivi, degradati e poco informativi.
Precisione e attenzione
Previsioni e precisione
Le previsioni del modello non riguardano solo l’entità del segnale, ma anche la sua precisione.
- Se ci aspettiamo un segnale preciso, l’errore di previsione viene amplificato
- Se ci aspettiamo un segnale impreciso, l’errore viene attenuato
L’attenzione come modulatore
Il meccanismo che guida questa amplificazione selettiva è l’attenzione.
Prestare attenzione significa aumentare l’errore di previsione per quello specifico segnale.
Neurobiologicamente, ogni neurone ha connessioni auto-inibitorie che moduliamo in senso discendente per aumentare o diminuire l’uscita del segnale.
Precisione e psicopatologia
Difficoltà nella stima della precisione
È più difficile stimare la precisione di un segnale rispetto alla sua entità.
- Entità = si calcola la media
- Precisione = si calcola la varianza → compito molto più complesso
Conseguenze cliniche
Alcune patologie potrebbero derivare da stime aberranti della precisione.
Autismo
- Stima di precisione troppo elevata
- Eccessiva fiducia nei dati sensoriali
- Tendenza a ricapitolare ossessivamente il dato sensoriale
- Risultato: modelli fragili e ansia
Schizofrenia
- Influenza eccessiva delle credenze pregresse
- L’errore non viene più utilizzato per correggere l’ipotesi
- Risultato: allucinazioni refrattarie
La percezione non è per la verità, ma per la sopravvivenza
Sembra che lo scopo della codifica predittiva sia una percezione fedele, ma in realtà serve a mantenere in vita l’organismo.
Un organismo riesce a contrastare la dissoluzione entropica solo minimizzando l’errore di previsione.
Friston e l’energia libera
Il neuroscienziato Karl Friston ha formalizzato il concetto con il principio dell’energia libera:
L’organismo vivente minimizza a lungo termine l’errore di previsione per sopravvivere.
Il Ruolo della meditazione
Meditazione Zen: caratteristiche principali
- Immobilità della postura e dello sguardo
- Non inseguire né sopprimere pensieri e sensazioni
- Attenzione elevata, soprattutto a livello propriocettivo
Effetti della meditazione
1. Valore epistemico
- Familiarizzazione con schemi mentali
- Attenzione al corpo = intercettare pensieri ansiogeni
2. Valore pragmatico
- Riconoscere l’impermanenza dei pensieri
- Aumenta flessibilità e creatività
Effetti fisiologici
Per operatori sanitari: la meditazione aiuta a normalizzare le risposte corporee in condizioni di stress.
L’attenzione elevata ai segnali corporei corregge i pensieri iniziali e interrompe il ciclo di auto-conferma.

Psicologo clinico, Guida in pratiche Meditative, Facilitatore in Mindfulness (ric. IPHM), Master DCA (Disturbi del Comportamento Alimentare), Master in Sessuologia Clinica, Master in Linguaggi della Psiche, Conoscitore in psicosomatica