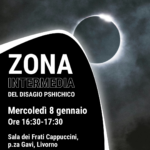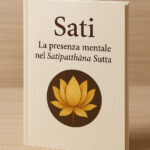Che cosa unisce la clinica junghiana, la neuroetologia di Jaak Panksepp e le attuali teorie sul cervello come sistema predittivo? Questo articolo dalla proposta di Antonio Alcaro di rileggere i complessi a tonalità affettiva di Carl Gustav Jung alla luce delle neuroscienze affettive.
L’idea di fondo è: al cuore dell’organizzazione psichica non ci sarebbero tanto “pensieri” o “rappresentazioni” isolate, quanto disposizioni affettivo-istintive endogene in grado di modellare il modo in cui interpretiamo il mondo e agiamo in esso.
Il lettore troverà qui una trattazione ampia (e volutamente “lenta”), arricchita di digressioni storiche, antropologiche e psicoanalitiche, esempi clinici, riferimenti a Varela e Maturana (autopoiesi, enattivismo), al cervello predittivo (Friston), alla neuropsicoanalisi (Solms) e alla tradizione comparata sul sogno. L’obiettivo è duplice: offrire un quadro aggiornato e insieme dare strumenti concettuali e pratici a terapeuti, ricercatori e lettori curiosi.
Se dovessimo condensare in un’immagine: pensate alla mente come a un arco di forze affettive che magnetizza idee, immagini e ricordi in costellazioni (i complessi). Queste costellazioni sono mobili, si intensificano, entrano in risonanza, si sciolgono: il loro centro di gravità è l’affetto.
In questo articolo
Cosa sono i “complessi a tonalità affettiva” di Jung
Per comprendere come le neuroscienze affettive di Panksepp e Jung possano incontrarsi, occorre tornare alla genealogia del concetto. Jung elabora i complessi sulla scia dei “complessi autonomi” descritti da Pierre Janet, osservando che nelle psicosi (ma in realtà nella mente di tutti) emergono nuclei tematici relativamente indipendenti dalla coscienza. Questi nuclei—insiemi di immagini, ricordi, parole, fantasie—sono tenuti insieme da una tonalità affettiva specifica: l’affetto è il centro organizzatore.
- Un complesso materno può aggregare memorie infantili, immagini della cura o della mancanza, fantasie di nutrimento o abbandono.
- Un complesso della casa può legare sicurezza, odori, suoni, genealogie, ma anche conflitti e separazioni.
È la tonalità affettiva a dare senso soggettivo al complesso e a renderlo saliente per quella persona. Per questo Jung preferisce parlare di affetto (esperienza soggettiva, qualitativa) rispetto alla pulsione freudiana (forza prepsichica). Nei complessi, l’affettività non è un’aggiunta; è il principio formale che tiene insieme il mosaico delle rappresentazioni.
Per un’introduzione a Jung: Introduzione a Jung – Stanford Encyclopedia of Philosophy.
Su Pierre Janet: Pierre Janet – Wikipedia.
Panksepp: le basi neuroetologiche dell’affetto
Con Jaak Panksepp (1943–2017), la psicologia dinamica incontra la biologia del comportamento. Nel suo classico Affective Neuroscience (1998), Panksepp individua sistemi affettivi di base subcorticali (SEEKING, FEAR, RAGE, LUST, CARE, PANIC/GRIEF, PLAY) che orchestrano motivazioni, emozioni e azioni negli animali e nell’uomo. Questi sistemi sono:
- Endogeni: non dipendono dall’apprendimento per esistere; sono circuiti predisposti.
- Motivanti: forniscono energia e direzione al comportamento.
- Organizzatori: strutturano la percezione (cosa notiamo), la memoria (cosa ricordiamo), la cognizione (come interpretiamo).
Il punto d’incastro con Jung è elegante: se i complessi sono costellazioni di senso tenute insieme da un affetto, Panksepp offre i circuiti neurofunzionali che generano quelle forze affettive. Di colpo, il modello simbolico-clinico di Jung acquisisce “radici” neurobiologiche; e, al contrario, la mappa neuroetologica di Panksepp riceve una semantica psicologica e clinica.
Approfondimenti:
Sogno: funzione compensativa e funzione prospettica (e perché oggi tornano attuali)
Jung attribuisce al sogno due funzioni principali:
- Compensativa: il sogno porta alla coscienza ciò che la coscienza diurna trascura, correggendo unilateralità (ad es., un eccesso di adattamento sociale che ignora bisogni intimi).
- Prospettica: il sogno anticipa sviluppi possibili, prepara scenari, indica direzioni di soluzione (non “profetico”, ma creativo e generativo).
Questa visione dialoga sorprendentemente con le attuali teorie del cervello predittivo—l’idea che il cervello sia un sistema generativo che simula il mondo e riduce l’incertezza (Free-Energy Principle, Karl Friston). Durante il sonno (specie in REM), l’inibizione prefrontale si allenta: il cervello ricombina memorie e affetti, esplora soluzioni meno vincolate dai filtri dell’attenzione. È il terreno ideale per la funzione prospettica junghiana.
- Per una sintesi accessibile: Predictive coding – Wikipedia
- Sui sogni e REM: Allan Hobson – Wikipedia
- Neuropsicoanalisi e sogno: Mark Solms – Wikipedia
L’intuizione di Panksepp sulla REM come “veglia arcaica”
Panksepp nota che i generatori della REM sono nel troncoencefalo, più antichi dei circuiti che regolano la veglia focalizzata. Propone allora un’ipotesi affascinante: la REM ripristina una forma di veglia arcaica, libera, esplorativa, meno incardinata sui meccanismi attentivi tipici dei vertebrati superiori. In REM, il SEEKING system può “vagare”, provare, agganciare elementi lontani: una condizione perfetta per la ricombinazione creativa che Jung chiama prospettiva e per la risonanza con i complessi trascurati (funzione compensativa).
In questa cornice, il sogno non è un semplice “riordino” mnestico, ma un laboratorio affettivo-generativo dove la mente riorganizza il proprio campo di attrattori.
Dall’esterno all’interno: perché il primato è dell’affettivo-endogeno
Il paradigma comportamentista prima e cognitivista poi ha privilegiato la traiettoria stimolo → elaborazione → risposta. La proposta endogena rovescia la freccia: prima ci sono disposizioni affettive che pre-strutturano il modo in cui vediamo, pensiamo e agiamo.
- Paura (FEAR): spinge all’evitamento; la percezione si sintonizza sui segnali di minaccia.
- Rabbia (RAGE): focalizza sull’ostacolo; aumenta la prontezza motoria al confronto.
- Ricerca (SEEKING): modulata da dopamina, rende gli stimoli interessanti, apre mappe cognitive.
In termini dinamici, gli affetti sono attrattori: configurazioni verso cui il sistema tende, che stabilizzano (o destabilizzano) i pattern di pensiero-percezione-azione. Qui l’eco con Jung è evidente: i complessi sono bacini di attrazione affettivi che organizzano rappresentazioni e condotte.
Un ponte con l’antropologia del sogno e del simbolo
Molte culture tradizionali considerano il sogno luogo di sapere e orientamento pratico (decisioni politiche, caccia, matrimonio). L’Occidente moderno, figlio dell’Illuminismo, ha declassato sogni e simboli a “rumore”. La psicoanalisi (Freud, poi Jung) e oggi la neuropsicoanalisi hanno rilegittimato l’onirico come funzione. In termini antropologici, potremmo dire: ogni cultura costruisce istituzioni per lavorare il sogno (riti, narrazioni, interpretazioni). Oggi, le neuroscienze affettive di Panksepp e Jung offrono cornici comuni per dialogare con queste sapienze: il sogno compensa unilateralità e progetta futuri possibili—un’idea intuitivamente nota agli sciamani così come ai laboratori creativi dei matematici.
Enattivismo, autopoiesi e il problema della soggettività
Francisco Varela e Humberto Maturana definiscono gli organismi come sistemi autopoietici: si producono e si mantengono attraverso le proprie operazioni. La cognizione, in questa prospettiva, è enattiva: emerge dall’incontro corpo-ambiente, non vive “in testa” come software astratto.
- Ciò risuona con l’idea che il vivente e il cognitivo siano due facce dello stesso processo.
- Tuttavia, il solo enattivismo rischia di spiegare l’organizzazione senza spiegare la qualità soggettiva (il “come si sente” dell’esperienza).
Qui la proposta di Alcaro è chiara: le disposizioni affettive endogene sono la materia calda della soggettività. Non bastano mappe sensori-motorie e predizione statistica; serve riconoscere che emozioni di base portano con sé valore e senso prima ancora delle rappresentazioni. Il dialogo con Antonio Damasio (emozione come rappresentazione di cambiamenti corporei) è fruttuoso ma resta la domanda: la rappresentazione corporea, da sola, spiega davvero il “tono” vissuto? La risposta, qui, tende al no: occorre ammettere un polo soggettivo originario, non riducibile a sola cognizione incarnata.
Approfondimenti:
Cervello predittivo, complessi e attrattori affettivi
La teoria predictive processing immagina il cervello come macchina generativa che minima l’errore di previsione. Come si incontrano complessi e attrattori affettivi con questo quadro?
- Gli affetti modulano la precisione delle previsioni: in paura, segnali di minaccia ricevono ipermaggiorazione (precision weighting).
- I complessi fungono da prior forti: non solo credenze, ma stati affettivi abituali che vincolano l’interpretazione (es.: “nessuno mi ascolta” come stato affettivo-cognitivo si auto-conferma).
- Il sogno offre una palestra di aggiornamento dei prior: ricombina e testa scenari, alterando le mappe di valore.
Questo ponte permette di integrare clinica profonda, neuroscienze affettive e computazione in una teoria ibrida che tenga insieme valore, senso e previsione.
Implicazioni cliniche: dal setting alla tecnica
1) Riconoscere i complessi come campi affettivi attivi
Non si tratta solo di “temi”. In seduta, un campo affettivo può occupare la stanza: stanchezza paralizzante (PANIC/GRIEF), irritazione diffusa (RAGE), ricerca febbrile di novità (SEEKING). Il terapeuta osserva ritmi, posture, micro-azioni, il tono delle parole.
2) Lavorare con sogni come dispositivi compensativi/prospettici
- Compensativo: “Cosa la tua vita diurna sta trascurando?”
- Prospettico: “Che linea di azione il sogno sta abbozzando?”
Si lavora per tradurre immagini in compiti di prova (micro-esperimenti tra una seduta e l’altra).
3) Integrare mindfulness e associazioni libere come flussi arcaici guidati
Entrambe sospendono la censura attentiva e permettono emersioni endogene: si facilita l’ascolto del campo affettivo, poi si ordina con parole, disegni, mappe.
4) Tecniche di tuning affettivo (regolazione dal basso)
Respiro, postura, micro-movimento, vocalizzazioni: non “psicotecniche” accessorie, ma chiavi per entrare nei sistemi affettivi di base e rimodularli.
5) Evitare la trappola “cognitivista pura”
La ristrutturazione cognitiva è preziosa, ma senza engagement affettivo rischia di restare epifenomenica. Prima agganciare l’affetto, poi rinominare e ridecidere.
Esempi clinici (compositi)
- Il paziente che sogna onde scure: di giorno è performante, iper-adattato; il sogno compensa (PANIC/GRIEF) e prospetta un “lasciarsi toccare”. Compito: un atto minimo di rallentamento (dieci minuti al giorno senza produttività), diario degli effetti.
- La professionista che sogna una scala mobile bloccata: RAGE trattenuta. Di giorno compiacente, nottetempo emergono impulsi di opposizione. Compito: “no” esplicito a una micro-richiesta. Si osservano oscillazioni del complesso e si negozia una nuova mappa di confini.
- Il creativo in burnout: SEEKING esaurito. Sogna un laboratorio caotico: prospettiva di gioco (PLAY) senza scopo. Compito: sessioni di gioco improduttivo (30’) con materiali non lavorativi, per riaccendere curiosità non strumentale.
Note storiche e curiose
- Jung e il test delle associazioni verbali: un protocollo psico-fisiologico ante litteram che misurava tempi di reazione e attriti in corrispondenza di parole “calde” (un assaggio di psicofisiologia dei complessi).
- Panksepp e il “laughter” dei ratti: la scoperta delle vocalizzazioni ultrasoniche associate al gioco (PLAY) ha mostrato quanto sociale e gioiosa possa essere la base affettiva animale, ben oltre paura e rabbia.
- Sogno e scienza: celebri intuizioni oniriche (Kekulé e il benzene, Poincaré e le funzioni fuchsiane) illustrano la funzione prospettica: la mente riunisce ciò che da svegli restava separato.
Domande frequenti (FAQ)
Il modello endogeno nega l’importanza dell’apprendimento?
No. Dice che l’apprendimento modula sistemi già predisposti. L’endogeno dà forma e direzione iniziale; l’esperienza plasma le traiettorie.
Dove si colloca la cultura?
Nel montaggio dei complessi: fornisce linguaggi, miti, pratiche interpretative che danno nome e significato ai campi affettivi.
Che rapporto c’è con l’EMDR, la terapia sensomotoria, la terapia polivagale?
Tutte riconoscono che la regolazione dal basso (corpo, ritmo, affetto) è condizione per l’elaborazione cognitiva stabile. La presente cornice spiega perché: gli attrattori affettivi organizzano i livelli superiori.
Le neuroscienze affettive di Panksepp e Jung sono compatibili con CBT ed ACT?
Sì, se si integra il lavoro sui valori/affetti (ACT) e si tratta la cognizione come emergente da stati affettivi (CBT di terza onda).
Conclusioni operative
- Mappare i complessi come campi affettivi (diario, sogni, situazioni trigger).
- Usare i sogni come segnalatori doppi: ciò che manca (compensazione) e ciò che chiama (prospettiva).
- Fare micro-esperimenti: spostare una cosa concreta nella vita (azione minima ad alta coerenza affettiva).
- Praticare tuning corporeo: respirazione, postura, voce; intervenire sul tono per rimodulare l’attrattore.
- Integrare: parola, corpo, immagine. Non alternative ma vettori coordinati.
Se dovessimo lasciare una bussola: le neuroscienze affettive di Panksepp e Jung suggeriscono che sentire è già conoscere—e che l’immaginazione onirica è un organo di orientamento per la vita.
Risorse utili
- Jung: Collected Works (riassunti) – Wikipedia
- Panksepp: Affective Neuroscience – Wikipedia
- Neuropsicoanalisi: International Neuropsychoanalysis Society
- Cervello predittivo: Karl Friston e Free-Energy – Wikipedia
- Autopoiesi ed enattivismo: Enactivism – Wikipedia

Psicologo clinico, Guida in pratiche Meditative, Facilitatore in Mindfulness (ric. IPHM), Master DCA (Disturbi del Comportamento Alimentare), Master in Sessuologia Clinica, Master in Linguaggi della Psiche, Conoscitore in psicosomatica